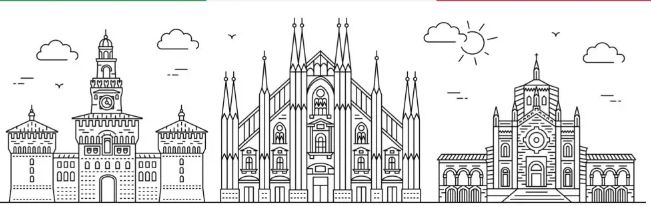Perché siamo tutti figli di Lehman Brothers

Il 15 settembre 2008 nella scatola di cartone che i giovani banchieri di Lehman Brothers si portavano in braccio lasciando i lussuosi uffici di New York di quella che era stata una delle grandi istituzioni finanziarie del pianeta e che era appena fallita trascinandosi dietro le economie di mezzo mondo, su ciascuna di quelle scatole, che contenevano gli oggetti personali dei manager, c’era una scritta invisibile, che siamo riusciti a leggere solo dieci anni dopo.
C’era scritto: Futuro. Ottimismo. Fiducia. Apertura. Tutte cose che stavano per andare in fumo assieme ai miliardi di dollari bruciati dal capitalismo più rapace.
Solo oggi infatti ci rendiamo conto che in fondo siamo tutti figli di Lehman Brothers; solo ora stiamo capendo che quel fallimento, che aprì la strada ad una crisi economica globale dalla quale l’Italia non è ancora definitivamente uscita, ha determinato il nostro modo di essere oggi. E quindi, di conseguenza, il quadro politico. A dirlo non è semplicemente una constatazione ma l’analisi oggettiva dei dati dell’osservatorio di SWG, che da vent’anni monitorano le opinioni e i sentimenti degli italiani.
Ebbene emerge chiaramente che il 2008 è stato l’anno di svolta, l’anno in cui l’Italia passa dall’essere una società aperta ad una che alza muri e invoca pistole. I grafici da questo punto di vista sono molto chiari: sono come quei giochi enigmistici in cui devi collegare dei puntini per scoprire la figura nascosta. La figura è un otto con due curve – mettiamo l’ottimismo e il pessimismo -, che si incrociano proprio a cavallo del 2008. Chi era in alto va in basso e viceversa. Cambia tutto.
Nel 2008, per esempio, il 62 per cento degli italiani pensa che l’Italia “si stia modernizzando”; oggi il 72 pensa che “stiamo regredendo”.
Nel 2007 il 51 per cento diceva di provare “un sentimento di inclusione” rispetto al resto del Paese; oggi il 68 per cento si dichiara “escluso” dai benefici del progresso.
Nel 2007 il 44 per cento sentiva di poter incidere sul proprio futuro; oggi sono appena il 26 per cento.
Nel 2009 il 53 per cento sentiva che dalla partecipazione all’Unione europea avevamo tratto più vantaggi che svantaggi; oggi lo sente appena il 18 per cento.
Infine, la progressiva chiusura verso l’immigrazione a cui assistiamo inizia nel 2003, è vero, ma dal 2008 ad oggi si sono persi 10 punti e oggi un sentimento di apertura è appannaggio solo di un italiano su tre (e ancora meno se si tratta di Islam).
Questi dati non si spiegano soltanto con la crisi economica globale iniziata nel 2008; e anzi non sarebbero interamente comprensibili se non tenessimo conto del fatto che a cavallo del 2008 succede un altro fatto altrettanto importante. Più che un fatto, si tratta di una autentica rivoluzione. La digitalizzazione infatti in quegli anni subisce una accelerazione mai vista con le precedenti rivoluzioni tecnologiche: arrivano gli smartphone (2007), le app (2008), le stampanti 3D (2009), la banda ultralarga (2010). L’elenco potrebbe andare avanti a lungo, con date che cambiano da paese a paese, ma il risultato è identico. E il risultato è che quando l’economia riparte da quella crisi profonda lo fa su basi completamente nuove: il famoso 4.0. Un nuovo paradigma di ideazione, prototipazione, produzione, distribuzione e consumo. Che quasi sempre ci vede impreparati dal punto di vista delle competenze digitali, e quindi ci propone lavoretti saltuari e sottopagati.
Tutto nasce in quell’anno. In quell’anno avviene il passaggio da sogni – chi sogna più oggi un mondo migliore? – a bisogni.
Averlo sottovalutato ci ha portato a dove siamo oggi.